Pubblicato il
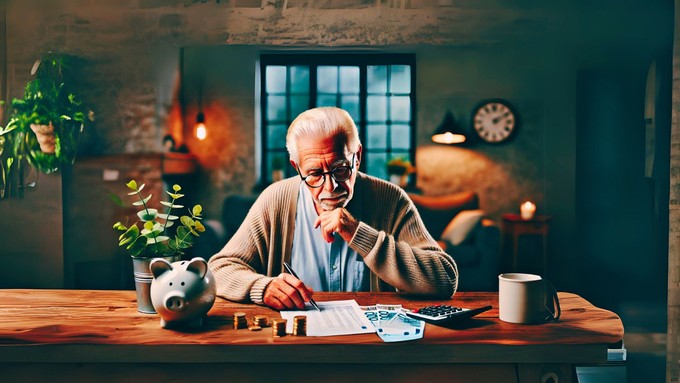
Le misure di raffreddamento della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS, introdotte dalla Legge di bilancio per il 2023, non violano i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza delle prestazioni pensionistiche.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, respingendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
Secondo la Corte, la normativa in esame non è irragionevole, in quanto tutela integralmente le pensioni di importo più basso e, per un periodo limitato, modula progressivamente la riduzione della perequazione per le pensioni più alte, che presentano una maggiore capacità di assorbire l'impatto dell'inflazione.
La decisione rientra nell'autonoma discrezionalità del legislatore in materia economica e previdenziale, finalizzata a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico e a bilanciare gli effetti della spinta inflazionistica, destinando risorse alle fasce di popolazione più vulnerabili.
Infine, la Corte ha sottolineato che eventuali future manovre sull'indicizzazione potranno tener conto delle perdite subite dai trattamenti pensionistici non pienamente rivalutati, garantendo una tutela complessiva nel tempo.
SENTENZA N. 19
ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e dell’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» promossi con ordinanze del 6 settembre e 27 novembre 2024 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, iscritte ai numeri 182 e 238 del registro ordinanze 2024, e con ordinanza dell’11 settembre 2024 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2024, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 41, 42 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visti gli atti di costituzione di M. P., di N. A. e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Sezione autonoma magistrati a riposo dell’Associazione nazionale magistrati;
udita nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
uditi gli avvocati Patrizio Ivo D’Andrea per la Sezione autonoma magistrati a riposo dell’Associazione nazionale magistrati, Salvatore Bianca per M. P. e per N. A., Antonella Patteri per l’INPS e l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 6 settembre 2024 (r.o. n. 182 del 2024), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nonché dell’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione.
2.– Nel giudizio principale, M. P. ha chiesto al giudice delle pensioni l’accertamento, per gli anni dal 2022 al 2024, del diritto (disconosciuto in sede amministrativa) alla rivalutazione integrale del trattamento pensionistico in godimento, superiore a dieci volte quello minimo applicato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3.– Il giudice a quo, in primo luogo, dichiara di essersi riservato di decidere sulla questione relativa all’ammissibilità della domanda di riconoscimento della perequazione per l’anno 2024, in quanto la relativa disciplina è stata oggetto di sopravvenienze normative successive al deposito del ricorso (il riferimento è all’art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»). Di conseguenza, ha circoscritto l’oggetto delle censure alla disciplina della rivalutazione dei trattamenti pensionistici per i soli anni 2022 e 2023.
4.– In punto di rilevanza, il rimettente osserva che solo con la declaratoria d’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni censurate la domanda del ricorrente potrebbe trovare pieno accoglimento: l’annullamento dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, infatti, consentirebbe solo il parziale riconoscimento della pretesa, dovendosi, nel caso, comunque applicare anche all’anno 2023 – come già sarebbe avvenuto per l’anno 2022, a seguito della sentenza n. 234 del 2020 di questa Corte – l’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che non consente comunque una rivalutazione completa dei trattamenti pensionistici.
5.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo si dichiara consapevole dei precedenti di questa Corte che hanno dichiarato non fondate questioni di legittimità costituzionale sollevate su analoghe previsioni di legge. Rileva, tuttavia, che le suddette disposizioni si inserivano «nel contesto delle manovre restrittive finalizzate ad assicurare il rispetto degli obiettivi eurounitari del Patto di Stabilità, con sacrifici diffusi richiesti a diverse categorie di soggetti».
La situazione sarebbe oggi differente, venendo in rilievo «per la prima volta […] una manovra di bilancio espansiva», nell’ambito della sospensione, a partire dal mese di marzo 2020, ma più volte prorogata, delle «regole del Patto di Stabilità a livello dell’UE».
5.1.– Con particolare riferimento all’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, il giudice a quo rileva che la disposizione, nel prevedere una riduzione progressivamente decrescente dell’indicizzazione delle pensioni (fino a un minimo del 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo INPS), ripropone «un meccanismo per fasce, analogo a quello in vigore nel biennio 2020-21», in sostituzione del sistema «dell’indicizzazione per scaglioni» previsto dall’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, con conseguente maggiore riduzione dell’importo finale della pensione.
Ciò premesso, l’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 sarebbe contrastante con plurimi parametri costituzionali.
5.1.1.– La limitazione della piena rivalutazione dei trattamenti pensionistici, riducendo «in modo particolarmente incisivo la proporzionalità e l’adeguatezza» della «retribuzione differita rappresentata dal trattamento pensionistico previdenziale» (ai sensi degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.), lederebbe «il fondamento lavoristico della Repubblica (art. 1, primo comma, Cost.)»: inserendosi nel contesto di una «manovra espansiva ed “in deficit”», infatti, il provvedimento legislativo destinerebbe stanziamenti particolarmente rilevanti a finalità diverse e «di minore pregnanza costituzionale».
L’imposizione di sacrifici a carico dei lavoratori in quiescenza, nell’ambito di interventi che, invece, attribuiscono a diverse altre categorie di soggetti «rilevanti provvidenze a carico del bilancio dello Stato», sarebbe altresì in contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
5.1.2.– Sempre al lume del principio da ultimo evocato, la misura di «“raffreddamento” dell’indicizzazione» delle pensioni più alte non sarebbe giustificabile neppure con il fine di contenere l’inflazione, «particolarmente elevata proprio nell’anno di riferimento della manovra», in quanto tale finalità è richiamata dalla legge solo dal comma 310 del medesimo art. 1 della legge n. 197 del 2022, che prevede l’erogazione di un contributo una tantum in favore dei soli titolari delle pensioni non superiori al minimo INPS.
Del resto, osserva ancora il rimettente, il notevole aumento dell’inflazione nel biennio 2022-2023 non sarebbe dipeso dalla «dinamica retributiva», ma dalle «tensioni sui mercati internazionali» (soprattutto dell’energia), cagionate dalla «complessa situazione geopolitica», nonché dall’aumento della domanda interna a seguito della ripresa dell’attività economica «al termine delle misure limitative del periodo pandemico».
5.1.3.– Riproducendo ampi stralci della sentenza n. 70 del 2015 di questa Corte, il rimettente si sofferma sui principi di adeguatezza e proporzionalità che devono sorreggere nel tempo i trattamenti pensionistici e sulla conseguente doverosità della loro perequazione automatica, pur nel contesto delle risorse finanziarie disponibili.
Le disposizioni censurate non sarebbero coerenti con i suddetti principi, presidiati dagli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., perché il loro effetto sarebbe quello di una «progressiva assimilazione» di trattamenti pensionistici di carattere previdenziale – da parametrare, in quanto retribuzione differita, «sulla “quantità e qualità” (art. 36, primo comma, Cost.) del lavoro svolto durante la vita attiva del lavoratore» – alle prestazioni di carattere assistenziale, da rapportare, invece, «esclusivamente o prevalentemente, allo stato di bisogno».
Ciò contrasterebbe anche con il rilievo attribuito al lavoro «quale elemento fondante della Repubblica (art. 1, primo comma, Cost.) e contributo al “progresso spirituale e materiale della società” (art. 4, secondo comma, Cost.)».
Il giudice a quo reputa «del tutto irrazionale prima promuovere i giovani più capaci al maggiore impegno nello studio», per contribuire alla crescita economica e culturale della società, anche in vista di una «conseguente retribuzione più alta dell’attività lavorativa svolta», per poi, «nella vecchiaia, disconoscere agli stessi l’importanza di un trattamento economico adeguato all’impegno lavorativo profuso in corso degli anni, superiore, per quantità e qualità, ai livelli minimi o medi».
Verrebbe lesa, in tal modo, anche «la stessa dignità del lavoratore in quiescenza» (tutelata dall’art. 3, secondo comma, Cost.), perché una pensione più alta rispetto alla media verrebbe considerata, non «come il meritato riconoscimento per il maggiore impegno e capacità dimostrati durante la vita economicamente attiva, ma alla stregua di un mero privilegio».
Del resto, aggiunge il rimettente, il “raffreddamento” della rivalutazione delle pensioni fornirebbe «un contributo negativo alle prospettive di crescita economica, cui è parimenti correlata la tenuta del sistema pensionistico», in quanto disincentiverebbe la popolazione più giovane ad impegnarsi nell’attività lavorativa in generale e, in particolare, in quella «regolare» (invece che nel «lavoro in nero», attributivo di immediati risparmi per oneri fiscali e previdenziali).
Ciò sarebbe dimostrato dai dati statistici sulla disoccupazione giovanile che registrano una «alta percentuale di cd. “giovani neet” (“Not in Education, Employment or Training”)» e livelli sempre bassi di occupazione femminile, questi ultimi asseritamente dovuti alla convenienza immediata di ottenere un risparmio di spesa conseguente all’impegno nell’attività di cura familiare.
5.1.4.– Sotto altro profilo, il rimettente osserva che l’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 «si pone in termini di continuità con le analoghe disposizioni degli anni precedenti», risultando in contrasto con «il principio della temporaneità delle misure».
Ancora una volta riportando stralci della citata sentenza n. 70 del 2015, evidenzia che «il sacrificio imposto al contribuente risulterà, per definizione, non transitorio bensì definitivo», perché le successive rivalutazioni saranno calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, già intaccato dal mancato adeguamento: in considerazione dell’«aspettativa di vita del pensionato», in sostanza, la misura – in quanto reiterata nel tempo – «da temporanea diventa definitiva», e perciò lesiva degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost.
5.1.5.– Il rimettente – «con specifico riferimento ai nn. 3), 4) e 5) della lett. b) della disposizione in esame» – rileva altresì una lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità retributiva presidiati dagli artt. 3 e 36 Cost., in considerazione del quantum delle riduzioni dell’indicizzazione, «al confronto con alcune altre disposizioni presenti nell’ordinamento civile che sembrerebbero espressioni di principi generali».
In particolare, il riconoscimento della rivalutazione della pensione in misura inferiore al cinquanta per cento sarebbe in contrasto con «il principio generale della peculiare rilevanza della lesione ultra dimidium» enunciato dall’art. 1448 del codice civile (in tema di azione generale di rescissione per lesione). A tale proposito, pur riconoscendo la «innegabile differenza tra l’esercizio dei poteri della discrezionalità legislativa ed i rapporti contrattuali tra i privati», il rimettente ravvisa «l’equivalente dello “stato di bisogno”» nella posizione del pensionato «che prima non poteva autonomamente determinarsi di non versare i contributi previdenziali obbligatori e ora dipende totalmente dalle decisioni del legislatore in merito alla misura della rivalutazione del trattamento pensionistico», nonché «l’indubbio vantaggio per lo Stato-creditore».
Ancora, tale limitato riconoscimento dell’indicizzazione sarebbe irragionevolmente «inferiore al tasso di interesse legale nel periodo di riferimento (art. 1284, comma 1, c.c.)», che spetterebbe, «in linea di principio, a tutti i creditori (art. 1282, comma 1, c.c.)».
5.2.– Con riferimento specifico all’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, il rimettente – pur riconoscendo che la disposizione è caratterizzata «da un’apparente minore lesività in concreto», in quanto le riduzioni ivi previste si applicano per scaglioni e «in misura contenuta» – ritiene che anch’esso contrasti: da un lato, con i principi di tutela della dignità del lavoratore e di adeguatezza e proporzionalità presidiati dagli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.; dall’altro, con il principio di temporaneità, «in relazione all’assenza di un limite temporale all’operatività della norma risalente al 2000», con conseguente violazione anche dell’art. 23 Cost.
6.– Si è costituito in giudizio M. P., il quale, condividendo le argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione, ha chiesto l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Per la parte privata, l’intervento legislativo in esame sarebbe ancora più lesivo dei parametri evocati dal rimettente, perché inserito «in un contesto caratterizzato da sostanziosi impulsi inflazionistici».
Evidenzia, ancora, che la limitata indicizzazione delle pensioni superiori a un certo importo si configurerebbe come «una tassazione impropria ed aggiuntiva, una vera “patrimoniale”», priva però dei requisiti di generalità, proporzionalità e progressività del prelievo e, per questo, lesiva dell’art. 53 Cost.
7.– Si è costituito in giudizio anche l’INPS.
Dopo aver ricordato che il ricorrente nel giudizio principale ha avuto accesso alla pensione liquidata in regime retributivo, con decorrenza dal mese di febbraio 2017, l’ente previdenziale ha chiesto di dichiarare non fondate le questioni sollevate sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, e inammissibili quelle prospettate in relazione all’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000.
Secondo l’INPS, il rimettente sarebbe incorso in un «travisamento […] sull’oggetto, sul senso e sul tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020», che non avrebbe affatto dichiarato l’illegittimità costituzionale del meccanismo di “raffreddamento” dell’indicizzazione delle pensioni previsto dall’art. 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ma avrebbe piuttosto censurato i successivi commi da 261 a 268, relativi al diverso istituto del «prelievo sulle pensioni di importo superiore a € 100.000 annui», peraltro «unicamente quanto alla durata superiore al triennio».
Di conseguenza, sarebbe errata l’affermazione del rimettente, secondo cui l’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 avrebbe trovato applicazione per l’anno 2022 in conseguenza di una declaratoria d’illegittimità costituzionale – in realtà insussistente – della disposizione della legge n. 145 del 2018 relativa alla limitazione dell’indicizzazione delle pensioni.
In ogni caso, evidenzia ancora la parte pubblica, per l’anno 2022 avrebbe comunque trovato applicazione l’art. 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), destinato a sostituire, a regime, il precedente meccanismo di cui all’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000.
Di qui, l’eccepita inammissibilità delle questioni sollevate su tale ultima disposizione.
Nel merito, l’INPS ha ricordato che la relazione tecnica di accompagnamento alla presentazione della legge di bilancio per il 2023 ha provveduto a indicare le cifre relative alla complessiva riduzione di spesa pensionistica, «con il conseguente effetto positivo sui conti dell’Istituto e sulla finanza pubblica», in progressione fino all’anno 2032. In particolare, per i primi tre anni, il risparmio ammonterebbe: «nel 2023 a 3.535 milioni al lordo degli oneri fiscali, e 2.121 milioni al netto; nel 2024 a 6.831 milioni al lordo degli oneri fiscali e a 4.098 al netto, nel 2025 a 6.589 milioni al lordo degli oneri fiscali e a 3.953 al netto».
Ciò premesso, l’ente previdenziale ha sostenuto che il meccanismo legislativo oggetto di scrutinio non intaccherebbe in maniera sproporzionata «la capacità di mantenere il tenore di vita acquisito» dai titolari di trattamenti pensionistici di più elevato importo, venendo in rilievo «un sacrificio del tutto ragionevole» a fronte di «significativi risparmi della spesa pubblica», ritenuti «di rilevanza decisiva», ai fini della «tenuta dei conti pubblici», in ossequio al dettato di cui all’art. 81 Cost.
A parere dell’INPS, la manovra economica complessiva per il 2023, lungi dal poter essere qualificata «espansiva» come «esito di fortunate condizioni economiche generali», sarebbe piuttosto il frutto della discrezionalità di scelta del legislatore, il quale, al cospetto di un quadro economico «problematico», avrebbe adottato «misure utili alla crescita economica, alle dinamiche di mercato e alla salvaguardia del sistema previdenziale», con interventi «in senso redistributivo», per garantire, al contempo, «la tenuta sia contabile sia sociale del sistema». La stessa «sospensione del patto di stabilità» valorizzata dal rimettente non sarebbe altro che uno strumento per consentire agli Stati nazionali interventi necessari, in favore di alcune categorie di beneficiari e «in condizioni eccezionali», per favorire la ripresa della crescita produttiva, messa «a dura prova anzitutto dalla pandemia», ma anche dalle «tensioni sui mercati energetici» e dalla «situazione geopolitica», fattori pure evocati dal giudice a quo.
Si tratterebbe di un bilanciamento frutto dell’esercizio non irragionevole della discrezionalità politica spettante al legislatore in merito alla destinazione delle risorse rispetto ai fini da raggiungere, non sindacabile se non in caso di superamento «dei limiti costituzionali di proporzionalità e adeguatezza», nella specie non valicati.
Infatti, osserva ancora la parte pubblica, ferma la rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici inferiori o pari a quattro volte quello minimo (quantificato in euro 515,58 per il 2021 e in euro 525,38 per il 2022, a valere per le rivalutazioni da calcolare, rispettivamente, per il 2022 e per il 2023), le percentuali di riduzione per i trattamenti di importo superiore sono state modulate in proporzione al crescere dell’importo, «senza peraltro mai giungere ad escludere totalmente la rivalutazione per alcun trattamento». Pertanto, la disposizione censurata sarebbe «conforme al canone di razionalità», individuato dalla sentenza n. 250 del 2017 di questa Corte, avendo il legislatore destinato le «limitate risorse finanziarie disponibili» in via prioritaria alle categorie di pensionati titolari degli assegni più bassi.
L’INPS, inoltre, esclude qualunque lesione della dignità dei pensionati, in contrasto con gli evocati artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma, Cost., con particolare riferimento ai titolari di pensione di importo medio-alto, la cui ridotta indicizzazione non potrebbe mai comportare – a differenza di quanto opinato dal rimettente – una «progressiva assimilazione dei trattamenti previdenziali a quelli assistenziali», alla luce della «piena attitudine dell’importo, pur rivalutato in misura ridotta, alla conservazione del tenore di vita acquisito».
Ancora, nessun fondamento avrebbe la pretesa del rimettente di applicare anche al meccanismo di “raffreddamento” della rivalutazione i limiti di temporaneità imposti dalla giurisprudenza costituzionale in relazione al ben diverso istituto dei contributi di solidarietà: questa Corte avrebbe già chiarito (è citata ancora la sentenza n. 250 del 2017) che il cosiddetto «effetto di “trascinamento” proprio delle censurate misure di blocco della perequazione non ne muta la natura di misure di mero risparmio di spesa e non di decurtazione del patrimonio del soggetto passivo».
Infine, del tutto inconferenti sarebbero i confronti operati dal rimettente con i principi desumibili dagli artt. 1282, 1284 e 1448 cod. civ.: l’assoluta eterogeneità delle situazioni messe a raffronto renderebbe il richiamo «totalmente eccentrico rispetto alla natura del rapporto previdenziale che trova fonte nella legge».
8.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.
Per la difesa erariale, alla base della disciplina censurata vi sarebbe «un interesse pubblico preciso, finalizzato a garantire un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato», indispensabile per la tenuta «del sistema Paese nel suo complesso», come emergerebbe con evidenza dai lavori preparatori della legge di bilancio per il 2023.
Il «contenimento della spesa pensionistica» così attuato, inoltre, non pregiudicherebbe «i diritti pensionistici nella loro essenza», in quanto essi, «seppur perequati in misura minore», risulterebbero adeguati a far fronte alle esigenze di vita del titolare e tali «da non mutare la reale disponibilità economica e il potere di acquisto del percettore».
9.– In data 20 dicembre 2024 M. P. ha depositato una memoria, con la quale ha ulteriormente illustrato il contenuto dell’atto di costituzione, anche alla luce degli argomenti addotti dall’INPS e dal Presidente del Consiglio dei ministri nei rispettivi atti.
Preso atto della scelta del rimettente di non sollevare questioni di legittimità costituzionale sulla disposizione che disciplina la rivalutazione da applicarsi per l’anno 2024, «vale a dire l’art. 1, comma 134 [recte: art. 1, comma 135], della legge 30 dicembre 2023, n. 213», la parte privata ha sollecitato, altresì, la declaratoria d’illegittimità costituzionale in via consequenziale anche di tale disposizione.
10.– Con ordinanza dell’11 settembre 2024 (r.o. n. 185 del 2024), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.
11.– Il giudice a quo riferisce che N. A. ha chiesto l’accertamento, per gli anni dal 2022 al 2024, del diritto (anche in tal caso negato in sede amministrativa) alla corresponsione del trattamento pensionistico – superiore a dieci volte quello minimo – senza l’applicazione della riduzione della rivalutazione automatica prevista dalla disposizione censurata.
12.– In punto di rilevanza, il rimettente osserva che l’accoglimento della domanda proposta nel giudizio principale presuppone «la rimozione, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale», della disposizione censurata.
13.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ricostruisce, in primo luogo, il quadro normativo e giurisprudenziale, compiendo un dettagliato excursus delle normative «susseguitesi in materia nel tempo».
Ricorda quindi che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici venne introdotta dall’art. 10 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e che fu l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) a stabilire che gli aumenti a titolo di perequazione fossero calcolati sul valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per il solo anno 1998, azzerò l’applicazione della perequazione automatica ai trattamenti superiori a cinque volte quello minimo INPS.
Con l’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), vennero definite le modalità concrete di applicazione della perequazione; mentre, con l’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, si introdusse una regola generale di “raffreddamento” di tutti i trattamenti pensionistici, applicabile «[a] decorrere dal 1° gennaio 2001».
Per l’anno 2008, tuttavia, l’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), escluse la rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte quello minimo.
Ancora una deroga fu apportata, per il biennio 2012-2013, dall’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che riconobbe la rivalutazione automatica per i soli trattamenti pensionistici fino a tre volte quello minimo.
Tale ultimo meccanismo fu dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, con la sentenza n. 70 del 2015, sicché il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109, sostituì il citato art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, riconoscendo, per il biennio 2012-2013, la parziale rivalutazione automatica anche in favore dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e pari o inferiori a sei volte quello minimo.
Per gli anni successivi al 2013, l’art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» per il periodo 2014-2016, e a esclusione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS (integralmente perequati), rivalutò quelli superiori secondo percentuali gradatamente ridotte, secondo un meccanismo prorogato fino al 2018 dall’art. 1, comma 286, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
In seguito, anche l’art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, per il periodo 2019-2021, sempre riconoscendo la rivalutazione completa dei trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, previde, per gli assegni superiori, indici ridotti progressivamente.
13.1.– In questo contesto andrebbe valutata la disposizione censurata, che riconosce la rivalutazione automatica integrale per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo, «poi dell’85%, 53%, 47% e 37%», al crescere dell’assegno, per giungere alla misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici – come quello spettante al ricorrente nel giudizio principale – complessivamente superiori a dieci volte il minimo INPS.
Dopo aver ricordato i principi espressi dalle pronunce di questa Corte che hanno scrutinato, nel tempo, le normative limitative della rivalutazione automatica di volta in volta adottate, il rimettente ha riprodotto uno stralcio della relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio per il 2023 e del relativo «dossier parlamentare», evidenziando che la disposizione censurata «costituisce l’ulteriore atto di una ininterrotta sequenza di provvedimenti che in modo sistematico comprimono la perequazione delle pensioni di importo medio alto», con l’unica eccezione dell’anno 2022, in cui, però, «l’indicizzazione non ha operato in considerazione di un tasso prossimo allo zero».
Ha osservato, inoltre, che il provvedimento legislativo in esame ha anche ripristinato il meccanismo della limitazione della rivalutazione «sull’importo complessivo del trattamento e non più a scaglioni, penalizzando così le pensioni più elevate».
In tal modo, la disposizione censurata – insuscettibile di essere interpretata in modo costituzionalmente conforme – si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., in quanto lederebbe i «fondamentali principi di ragionevolezza, proporzionalità e conservazione del trattamento pensionistico», da considerare quale retribuzione differita, di cui deve essere garantita nel tempo la sufficienza e l’adeguatezza, anche in rapporto alle variazioni del costo della vita.
Secondo il rimettente, infatti, misure destinate a produrre effetti pregiudizievoli su diritti soggettivi perfetti attinenti a rapporti di durata possono definirsi rispettose del canone della ragionevolezza solo se le «decurtazioni previste» siano imposte da esigenze straordinarie di contenimento della spesa pubblica e presentino un’efficacia temporale limitata e circoscritta «che non modifichi a regime i diritti incisi» e che sia «strettamente preordinata a coprire un arco temporale pari a quello al quale sono riferite le esigenze di bilancio che hanno determinato (e giustificato) l’intervento».
Tanto premesso, la disposizione censurata presenterebbe, invece, significative «criticità».
In primo luogo, dalla documentazione parlamentare riprodotta per stralci non si ravviserebbe «la rappresentazione delle specifiche esigenze di contenimento della spesa».
Inoltre, la misura sarebbe «fortemente penalizzante per le pensioni medio alte», in quanto comprimerebbe «in modo significativo il relativo potere d’acquisto»: aggiungendosi a meccanismi di blocco o limitazione della perequazione operativi già da oltre quindici anni, il provvedimento in esame assumerebbe una connotazione «tutt’altro che transitoria con un effetto di trascinamento e di definitività idonei a minare in misura significativa i margini di resistenza dei trattamenti pensionistici medio-alti».
Una perdita di potere d’acquisto non più recuperabile, dunque, dal momento che le successive rivalutazioni verranno calcolate non sul valore reale originario, ma «sull’ultimo importo nominale eroso dal mancato adeguamento».
In definitiva, per il rimettente, la disposizione censurata modificherebbe, «in peius e a regime» – e non con efficacia temporanea e strumentale al soddisfacimento di «straordinarie esigenze finanziarie» – diritti patrimoniali attinenti a rapporti di durata, senza che risultino «chiare le specifiche esigenze di contenimento della spesa» sottese alla scelta legislativa. In tal modo sarebbe «minata la principale finalità di tutela della perequazione, che è quella di prevedere una difesa del potere d’acquisto delle pensioni».
14.– Si è costituito in giudizio N. A., aderendo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, di cui ha chiesto l’accoglimento.
Ha aggiunto che la limitata indicizzazione delle pensioni superiori a un certo importo si configurerebbe come «una prestazione patrimoniale di natura tributaria posta a carico di una sola categoria di contribuenti, in violazione del principio dell’universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva e del principio di eguaglianza».
15.– Anche in tale giudizio si è costituito l’INPS.
Ha esposto le cifre indicate nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio per il 2023 in ordine ai risparmi di spesa assicurati fino al 2032 e ha ribadito le argomentazioni a difesa della disposizione censurata già dedotte nel giudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024 e illustrate al precedente punto 7.
Ha pure riferito che il ricorrente nel giudizio principale ha avuto accesso alla pensione liquidata in regime retributivo, con decorrenza dal mese di settembre 2021, aggiungendo che la questione di legittimità costituzionale fondata sull’asserito carattere non transitorio della misura, per effetto della reiterazione nel tempo di meccanismi analoghi, sarebbe «carente di rilevanza nel giudizio a quo», alla luce del fatto che il ricorrente «è entrato in quiescenza nel settembre 2021», sicché gli interventi normativi precedenti non avrebbero avuto alcun effetto sulla posizione di pensionato dell’istante, «che tale non era al momento in cui i suddetti interventi hanno spiegato efficacia».
16.– Rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto anche in questo giudizio, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate e articolando difese del tutto sovrapponibili a quelle dedotte nel giudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024, compendiate al precedente punto 8.
17.– È intervenuta in giudizio anche la Sezione autonoma magistrati a riposo dell’Associazione nazionale magistrati, diffusamente motivando in ordine all’ammissibilità dell’intervento e, nel merito, anch’essa condividendo le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
18.– In data 20 dicembre 2024, N. A. ha depositato una memoria, con la quale ha ulteriormente illustrato il contenuto dell’atto di costituzione, anche alla luce degli argomenti addotti dall’INPS e dal Presidente del Consiglio dei ministri nei rispettivi atti.
In aggiunta, ha evidenziato la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori «ancora in servizio», per i quali la rivalutazione avverrebbe «automaticamente ed annualmente», in violazione del «principio di non discriminazione basato sull’età».
19.– Anche l’interveniente Sezione autonoma magistrati a riposo dell’Associazione nazionale magistrati ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito gli argomenti addotti nell’atto d’intervento e, a ulteriore supporto della loro fondatezza, ha prodotto una relazione tecnica sulla posizione previdenziale di uno dei magistrati a riposo associati.
20.– Nei giudizi di cui al r.o. n. 182 e n. 185 del 2024 hanno depositato opinioni, in qualità di amici curiae e ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’Associazione Comma2 - Lavoro è dignità e la Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità (CIDA), argomentando in senso adesivo alle censure del rimettente.
Tali opinioni sono state ammesse con decreti presidenziali del 17 dicembre 2024.
21.– Con ordinanza del 27 novembre 2024 (r.o. n. 238 del 2024), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, per contrasto con gli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma e 38, secondo comma, Cost.
22.– Il rimettente ha riferito che C.A. T. ha chiesto al giudice delle pensioni l’accertamento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del diritto (anche questo disconosciuto in sede amministrativa) alla rivalutazione integrale del trattamento pensionistico in godimento, «rientrante nella fascia di riferimento “oltre 6 e fino a 8 volte” il minimo INPS».
23.– Il giudice a quo, in primo luogo, ha dichiarato di essersi riservato, anche in questo giudizio, di decidere sulla questione relativa all’ammissibilità della domanda di riconoscimento della rivalutazione integrale per l’anno 2024, per le stesse ragioni espresse nell’ordinanza iscritta al r.o. n. 182 del 2024 e compendiate al precedente punto 3.
24.– Risultano del tutto analoghe a quelle esibite dall’ordinanza iscritta al r.o. n. 182 del 2024 anche le argomentazioni a sostegno della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, riportate nel precedente punto 4.
25.– Ciò premesso, il rimettente ha riprodotto l’identica motivazione, riassunta nel precedente punto 5, in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento all’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, pur dando atto delle differenze dei casi concreti. Queste ultime sono individuate nella prevista rivalutazione pari al 47 per cento del trattamento pensionistico oggetto di causa e nella mancata estensione della domanda del ricorrente alla rivalutazione integrale anche per l’anno 2022.
26.– Anche in questo giudizio si è costituito l’INPS.
Emerge dalle difese dell’ente previdenziale che il ricorrente nel giudizio principale ha avuto accesso alla pensione liquidata in regime retributivo, con decorrenza dal mese di dicembre 2012.
La parte pubblica ha poi esposto le cifre indicate nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio per il 2023 in ordine ai risparmi di spesa assicurati fino al 2032 e ha ribadito le argomentazioni a difesa della disposizione censurata già dedotte nel giudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024 e riassunte al precedente punto 7.
27.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto anche in tale giudizio, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate, sulla base di difese del tutto analoghe a quelle dedotte nel giudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024, riepilogate al precedente punto 8.
Considerato in diritto
1.– Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Toscana (r.o. n. 182 e n. 238 del 2024) e per la Regione Campania (r.o. n. 185 del 2024) sollevano questioni di legittimità costituzionale, complessivamente, dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) e dell’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), entrambe disposizioni che incidono sui meccanismi di adeguamento degli assegni pensionistici alle variazioni del costo della vita.
In particolare, l’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che, per l’anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente: 85 per cento per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53 per cento per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47 per cento per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37 per cento per quelli rientranti nell’intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo.
L’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, dal suo canto, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato per fasce di importo dei trattamenti pensionistici: a) nella misura del 100 per cento per quelle fino a tre volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per quelle comprese tra tre e cinque volte tale soglia; c) nella misura del 75 per cento per quelle superiori a cinque volte il suddetto limite minimo.
2.– In tutti i giudizi principali, i ricorrenti hanno chiesto al giudice delle pensioni – per gli anni dal 2022 al 2024, nei giudizi di cui al r.o. n. 182 e n. 185 del 2024, e a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel giudizio di cui al r.o. n. 238 del 2024 – l’accertamento del diritto (disconosciuto in sede amministrativa) alla rivalutazione integrale dell’assegno in godimento, nei primi due casi superiore a dieci volte il trattamento minimo e, nel terzo, di importo compreso tra le sei e le otto volte tale soglia di riferimento.
3.– Per i rimettenti, esclusivamente l’accoglimento delle questioni sollevate consentirebbe l’integrale rivalutazione dei trattamenti pensionistici richiesta dai ricorrenti.
La sola ordinanza iscritta al r.o. n. 182 del 2024 ritiene che, in caso di accoglimento delle questioni sollevate sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici per l’anno 2023 tornerebbe a essere disciplinata dall’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, asseritamente già applicato per l’anno 2022. Di conseguenza, viene censurata pure tale disposizione, nel suo escludere anch’essa la completa indicizzazione delle pensioni medio-alte.
4.– In punto di non manifesta infondatezza, l’articolazione delle doglianze avanzate dai diversi rimettenti segue percorsi solo parzialmente sovrapponibili.
4.1.– In relazione all’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, tutte le ordinanze ne sospettano il contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.
Specifiche doglianze sono avanzate dalla sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti, in riferimento anche agli artt. 1, primo comma, 4, secondo comma, e 23 Cost.
4.2.– La sola ordinanza iscritta al r.o. n. 182 del 2024 ritiene che pure l’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) contrasti con tutti i parametri innanzi indicati.
5.– Poiché i suddetti atti introduttivi mirano al medesimo risultato ed evocano parametri largamente coincidenti, i tre giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
6.– Con ordinanza dibattimentale, allegata a questa pronuncia, è stato dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla Sezione autonoma magistrati a riposo dell’Associazione nazionale magistrati nel giudizio iscritto al r.o. n. 185 del 2024.
7.– Per comprendere la portata dei dubbi di legittimità costituzionale qui sollevati, nonché per rispondere alle eccezioni preliminari avanzate dall’INPS, è necessario ripercorrere, sia pur sinteticamente, l’evoluzione degli interventi legislativi che hanno inciso sulla dinamica rivalutativa degli assegni pensionistici.
Come ricordato, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020, la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, disciplinata inizialmente dall’art. 10 della legge n. 903 del 1965, nacque come meccanismo volto ad adeguare le pensioni ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, ben presto agganciato all’aumento percentuale dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della “scala mobile” delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria.
Sopravvenuta l’abolizione della scala mobile (per effetto del protocollo d’intesa del 31 luglio 1992), allo scopo di compensare l’eliminazione dell’aggancio alle dinamiche salariali e collegare l’adeguamento delle pensioni all’evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale, l’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, stabilì che gli aumenti a titolo di perequazione fossero calcolati sul valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Già in epoca risalente, tuttavia, il legislatore cominciò a intervenire per “rallentare” la dinamica perequativa.
L’art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997, per la prima volta e per il solo anno 1998, azzerò l’applicazione della perequazione automatica ai trattamenti di importo medio-alto, ossia superiori a cinque volte il trattamento minimo.
In seguito, con l’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, vennero fissate le regole di applicazione che, a tutt’oggi governano la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, in virtù del costante rinvio a tale disposizione operato dai successivi interventi legislativi, inclusi quelli oggetto dell’odierno scrutinio. La rivalutazione si applica, per ogni singolo beneficiario, «in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti» percepiti, con la precisazione che l’aumento dovuto viene attribuito «in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo».
Poco dopo, il qui censurato art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 previde il sistema di “raffreddamento” della perequazione pensionistica illustrato al precedente punto 1, rendendolo permanente in quanto destinato a operare «[a] decorrere dal 1° gennaio 2001».
Nel tempo, tale regola generale è stata più volte oggetto di deroghe, nella maggior parte dei casi finalizzate a moderare ulteriormente, per periodi limitati, la progressione rivalutativa degli assegni pensionistici. E su tali deroghe si è ripetutamente espressa questa Corte.
Così, per il solo anno 2008, l’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 escluse la rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte quello minimo, superando indenne lo scrutinio di legittimità costituzionale (sentenza n. 316 del 2010).
Ancora, per il biennio 2012-2013, l’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, riconobbe la rivalutazione automatica per i soli trattamenti pensionistici fino a tre volte quello minimo, escludendola per tutti quelli di importo superiore.
Sopravvenuta la declaratoria d’illegittimità costituzionale di tale esclusione per effetto della sentenza di questa Corte n. 70 del 2015, il d.l. n. 65 del 2015, come convertito, sostituì il citato comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, riconoscendo, per il biennio 2012-2013, la rivalutazione automatica anche in favore dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e pari o inferiori a sei volte quello minimo, secondo un meccanismo – scrutinato positivamente dalla sentenza n. 250 del 2017 – decrescente in relazione inversa rispetto alla misura delle pensioni, ma confermando il blocco totale della perequazione per i trattamenti di ammontare superiore.
Il modello dell’indicizzazione decrescente in base all’importo dell’assegno pensionistico era stato già introdotto, per gli anni successivi al 2013, dalla legge n. 147 del 2013, il cui art. 1, comma 483, lo aveva applicato, per il periodo 2014-2016, a tutti i trattamenti pensionistici, ancora una volta salvaguardando integralmente solo quelli pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, con un meccanismo uscito indenne dalle censure di illegittimità costituzionale pure sollevate (sentenza n. 173 del 2016) e quindi prorogato, in forma sostanzialmente invariata, fino al 2018 dalla legge n. 208 del 2015.
In seguito, l’art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, per il periodo 2019-2021, riconobbe la rivalutazione automatica mediante un modulo del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio: ferma la rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, gli indici vennero ridotti al 97 per cento (per gli assegni pari o inferiori a quattro volte il minimo), al 77 per cento (per quelli tra quattro e cinque volte la suddetta soglia), al 52 per cento (per quelli tra cinque e sei volte il limite INPS), al 47 per cento (per quelli tra sei e otto volte il minimo INPS), al 45 per cento (per quelli tra otto e nove volte il livello minimo), per giungere infine al 40 per cento riconosciuto alle pensioni complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
Al contempo, l’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 introdusse una nuova regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica, destinata a operare dal 1° gennaio 2022. A partire da tale data, si prevede che l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni venga applicato per fasce di importo: a) nella misura del 100 per cento per quelle fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per quelle comprese tra quattro e cinque volte tale soglia; c) nella misura del 75 per cento per quelle superiori a cinque volte il suddetto limite minimo.
Si giunge, quindi, all’altra disposizione oggi censurata (art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022), in origine destinata a operare per il biennio 2023-2024, ma poi modificata dall’art. 1 della legge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l’ambito applicativo al solo anno 2023 (comma 134), riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo, a parte un’ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto al 32 per cento vigente per il 2023) dell’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo.
8.– Così ricostruito il quadro normativo, e prima di affrontare il merito delle questioni sollevate, occorre definire con precisione il thema decidendum.
8.1.– Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, infatti, non possono essere presi in esame questioni o profili di costituzionalità dedotti solo dalle parti e diretti quindi ad ampliare o modificare il contenuto dell’ordinanza di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 144, n. 140 e n. 112 del 2024).
Nel caso di specie, le parti private hanno prospettato una lesione dei principi di uguaglianza e di progressività del prelievo tributario, presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost., perché la limitata indicizzazione delle pensioni superiori a un certo importo si configurerebbe come: «una tassazione impropria ed aggiuntiva, una vera “patrimoniale”», priva però dei requisiti di generalità, proporzionalità e progressività del prelievo (nel giudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024); «una prestazione patrimoniale di natura tributaria posta a carico di una sola categoria di contribuenti, in violazione del principio dell’universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva e del principio di eguaglianza», con conseguente disparità di trattamento anche rispetto ai lavoratori «ancora in servizio» (nel giudizio di cui al r.o. n. 185 del 2024).
Si tratta di profili che i rimettenti non hanno inteso fare oggetto di specifiche questioni, sicché essi, in quanto diversi da quelli individuati dalle ordinanze di rimessione, non devono essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte.
8.2.– Tutti i rimettenti, inoltre, limitano l’oggetto dello scrutinio demandato a questa Corte alla disciplina della rivalutazione per l’anno 2023 (in un caso – ordinanza iscritta al r.o. n. 182 del 2024 – prospettando possibili ricadute anche in riferimento all’anno 2022), riservando all’esito del giudizio costituzionale l’esame dell’ammissibilità della domanda, avanzata nei giudizi a quibus, di riconoscimento della rivalutazione integrale anche per il 2024. Ciò perché, come innanzi ricordato (precedente punto 7), la disciplina applicabile a tale anno, non censurata in questa sede, è stata modificata dall’art. 1, comma 135, della legge n. 213 del 2023, successiva al deposito dei ricorsi introduttivi dei giudizi principali.
9.– Ancora in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni formulate dall’INPS.
9.1.– In primo luogo, l’ente previdenziale ha eccepito l’inammissibilità delle questioni sollevate, nel giudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024, in riferimento all’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, non ritenendolo applicabile nel giudizio principale, neppure in caso di accoglimento delle questioni sollevate sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022.
L’eccezione è fondata.
Al precedente punto 7 si è già rilevato come la regola generale di raffreddamento della dinamica rivalutativa delle pensioni che il suddetto art. 69, comma 1, aveva introdotto a far data dal 1° gennaio 2001, già più volte derogata dalla legislazione successiva, è stata sostituita, a partire dal 1° gennaio 2022, dal meccanismo limitativo previsto dall’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019. Quest’ultima, dunque, è l’unica disposizione che, già applicata nell’anno 2022, sarebbe chiamata a governare la perequazione dei trattamenti pensionistici per l’anno 2023, nel caso di accoglimento delle questioni sollevate sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022.
Le questioni riferite all’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 sono dunque inammissibili per difetto di rilevanza, avendo a oggetto disposizioni delle quali la Corte dei conti rimettente non sarebbe mai chiamata a fare applicazione nel giudizio principale (ex plurimis, sentenza n. 103 del 2023).
9.2.– Inoltre, nell’ambito del giudizio di cui al r.o. n. 185 del 2024, l’INPS ha eccepito l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale riferita all’asserito carattere non transitorio della misura limitativa dell’indicizzazione, per effetto della reiterazione nel tempo di meccanismi analoghi: essendo il ricorrente pensionato dal settembre 2021, si afferma, gli interventi normativi precedenti non avrebbero avuto alcun effetto sulla sua posizione pensionistica.
L’eccezione non è fondata.
La complessiva critica del rimettente si incentra anche sull’effetto di “trascinamento”, che si produce pure in conseguenza della sola mancata rivalutazione annuale prevista dalla disposizione censurata, certamente applicabile nel giudizio a quo, sicché la contestazione sembra impingere il merito della censura, piuttosto che la sua ammissibilità.
10.– Nel merito, tutte le questioni sollevate non sono fondate, alla luce dei precedenti di questa Corte, esaustivamente compendiati, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020.
Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016).
La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza” (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018).
La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017).
È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall’altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017).
11.– In linea con quanto ora esposto, anche la misura introdotta dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati.
12.– Tutti i rimettenti reputano la disposizione contrastante con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., innanzitutto perché il modulo perequativo imposto per il 2023 – in deroga alla regola generale individuata in quella contemplata dall’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 – avrebbe ingiustificatamente, e dunque irragionevolmente, peggiorato i trattamenti pensionistici di importo più elevato, senza una chiara illustrazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta legislativa.
Inoltre, aggiungendosi a ripetuti meccanismi limitativi della rivalutazione delle pensioni imposti negli ultimi quindici anni, la misura avrebbe determinato la sostanziale definitività della perdita connessa alla pur temporanea riduzione degli indici di recupero del potere di acquisto, con un conseguente effetto di “trascinamento” intollerabilmente lesivo dei margini di resistenza all’inflazione anche dei trattamenti medio-alti; ciò in frontale contrasto con le garanzie di proporzionalità e adeguatezza di cui gli evocati parametri circondano l’assegno pensionistico, per la sua natura di retribuzione differita.
12.1.– Al contrario, va evidenziato che il modulo di “raffreddamento” qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte.
In particolare, rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, ritenuto dalla sentenza n. 234 del 2020 compatibile con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali, l’odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun “contributo di solidarietà” aggiuntivo.
Il congegno normativo in discorso salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un “rallentamento” della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest’ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell’inflazione.
12.2.– A differenza di quanto sostenuto dai rimettenti, le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643).
In particolare, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che l’iniziativa legislativa «si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell’aumento dell’inflazione, dovuto principalmente all’incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime». A fronte di ciò, si chiarisce che «l’impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l’impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili».
Il documento conferma che la manovra di finanza pubblica comporta «un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 23,7 miliardi di euro nel 2023» e che, quindi, le misure adottate per raggiungere gli obiettivi indicati sono assunte in deficit (ossia con il ricorso ad ulteriore indebitamento), come consentito dalla temporanea sospensione delle regole europee del patto di stabilità.
In questo complessivo contesto – di cui pure i rimettenti paiono pienamente consapevoli – si collocano anche gli interventi nel settore della previdenza.
Sempre la relazione illustrativa specifica che il meccanismo di indicizzazione delle pensioni qui scrutinato consente una minore spesa che «al netto degli effetti fiscali» è «pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025».
A sua volta, la relazione tecnica chiarisce che «[t]ali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico».
Alla luce di tale carattere “strutturale”, gli effetti della misura, pur se di applicazione limitata (originariamente ad un biennio e poi) ad un anno, si proiettano anche al di là dell’orizzonte triennale della manovra, come è reso evidente dall’indicazione delle «economie in termini di minore spesa pensionistica» previste fino all’anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 miliardi di euro.
La stessa relazione, inoltre, illustra in dettaglio la distribuzione del “monte pensioni” in relazione alle soglie introdotte dalla normativa in esame.
Da tali dati emerge che le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del 2020 – ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo – rappresentano l’11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di “elasticità” rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso.
La relazione illustrativa del disegno di legge, peraltro, individua anche ulteriori interventi che la misura in esame contribuisce a finanziare.
Alcuni di essi si collocano nel medesimo ambito previdenziale, quali: la proroga di istituti che favoriscono il pensionamento anticipato, come la cosiddetta “quota 103” (commi da 283 a 285 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022); l’indennità cosiddetta “ape sociale” (commi da 288 a 291) e la cosiddetta “opzione donna” (comma 292). A ciò si aggiunge il sussidio una tantum per le pensioni minime, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche (comma 310).
Altri interventi, pur estranei al circuito previdenziale, rientrano comunque nel più ampio settore “lavoro, famiglia e politiche sociali” (di cui al Titolo IV dell’originario disegno di legge, comprendente anche la misura oggetto dell’odierno scrutinio): la maggiorazione del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell’assegno unico universale, al ricorrere di certe condizioni (commi 357 e 358); l’incremento dell’indennità per congedo parentale (comma 359); il riordino delle misure di sostegno alla povertà e dirette all’inclusione lavorativa (commi da 313 a 321), eccetera.
Si tratta di interventi che non possono essere qualificati «di minore pregnanza costituzionale» (come sostenuto nei giudizi di cui al r.o. n. 182 e n. 238 del 2024). Essi perseguono finalità che rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili» (sentenza n. 234 del 2020).
12.3.– La misura in esame, per come congegnata, risulta rispettosa dei parametri evocati, anche se costituisce l’ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo.
La lettura offerta dai rimettenti del monito lanciato da questa Corte con la sentenza n. 316 del 2010 – secondo cui «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» – collide con il dato di fatto che il meccanismo qui scrutinato non comporta «l’effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati», come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore.
12.3.1.– Con particolare riguardo all’effetto di “trascinamento”, normalmente conseguente a ogni limitazione dell’indicizzazione, questa Corte ha già affermato che «il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)» (ancora sentenza n. 234 del 2020).
A maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione.
Nulla esclude, peraltro, che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici.
12.4.– Questa Corte, pur nella consapevolezza che ogni bilanciamento tra interessi finanziariamente condizionati risente inevitabilmente del mutamento della congiuntura economica, non può tuttavia esimersi – in sintonia con l’auspicio espresso dalle sezioni riunite della Corte dei conti nella delibera adottata in sede di controllo sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (n. 40/SSRRCO/AUD/2022) – dal sottolineare i vantaggi che deriverebbero da una «disciplina più stabile e rigorosa» del meccanismo di perequazione delle pensioni. Del resto, l’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 ha già dettato una regola che, in ossequio alla durata indeterminata espressamente conferitale, dovrebbe essere interessata con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie.
13.– Inoltre, la sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti denuncia la medesima disposizione sotto ulteriori profili, con censure che si rivelano del pari non fondate.
13.1.– Si sostiene, in primo luogo, che – sempre in lesione dei parametri innanzi indicati – il freno all’incremento automatico delle pensioni più alte, inserito nel contesto di una «manovra espansiva ed “in deficit”», sarebbe strumentale al finanziamento di altri obiettivi «di minore pregnanza costituzionale», che dovrebbero essere finanziati con «risorse provenienti dalla fiscalità generale»: ciò sarebbe irragionevole, in confronto alla preponderante necessità di assicurare proporzionalità e adeguatezza di tutti i trattamenti pensionistici, al lume del «fondamento lavoristico della Repubblica» (art. 1, primo comma, Cost.).
Orbene, se si può certamente convenire sul fatto che si sia al cospetto di una manovra espansiva quanto alle spese «ed “in deficit”», tuttavia non erra l’INPS nell’evidenziare che l’intervento legislativo non può essere letto come distribuzione di risorse derivanti da «fortunate condizioni economiche generali”», che avrebbe perciò irragionevolmente penalizzato solo i percettori di pensioni medio-alte.
Le opzioni politiche sottese alla manovra, come illustrato negli atti parlamentari in precedenza indicati, mirano invero a rispondere alle difficoltà sociali cagionate da una forte e imprevedibile spinta inflazionistica causata da tensioni geopolitiche, che ha portato a un brusco innalzamento dei prezzi di servizi irrinunciabili connessi al mercato dell’energia, in un contesto economico generale ancora caratterizzato dalla necessità di uscire dalla grave crisi economica determinata dalla pandemia da COVID-19.
Una realtà economico-sociale – di cui anche i pensionati devono essere «partecipi e consapevoli» (sentenza n. 173 del 2016) – che esclude qualsivoglia connotato di arbitrio delle scelte legislative tese a neutralizzare gli effetti prodotti sulle classi sociali meno agiate.
13.2.– Il modulo perequativo in esame non può qualificarsi manifestamente irragionevole neppure alla luce della sua inidoneità – postulata dai rimettenti con ulteriore censura – a contenere l’inflazione, il cui elevato aumento nel biennio 2022-2023 non sarebbe dipeso dalla «dinamica retributiva» interna, ma dai fattori esogeni appena ricordati.
La doglianza, infatti, presuppone erroneamente che, per non risultare arbitrario, ogni provvedimento di raffreddamento della dinamica perequativa debba necessariamente mirare a combattere la pressione inflazionistica.
In realtà, tale scopo non appare affatto necessario (come dimostra il contesto di inflazione marginale in cui è stata adottata la misura positivamente scrutinata dalla sentenza n. 234 del 2020), bastando che il legislatore illustri in dettaglio le finalità di politica economica che intende di volta in volta perseguire, selezionandole alla luce delle risorse disponibili, e che le misure adottate appaiano coerenti con tali finalità.
13.3.– Evocando anche l’art. 4, secondo comma, Cost., si afferma, poi, che l’intervento legislativo censurato, aggiungendosi ai precedenti, avrebbe determinato una progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici alle prestazioni di carattere assistenziale, parametrate «esclusivamente o prevalentemente, allo stato di bisogno».
Ma coglie ancora nel segno la difesa dell’INPS, secondo cui «pare sufficiente scorrere i valori degli scaglioni previsti della norma per rilevare che una tale eventualità è del tutto esclusa nei fatti».
13.4.– Per i rimettenti sarebbe lesa, altresì, la «dignità del lavoratore in quiescenza», la cui pensione più alta rispetto alla media verrebbe considerata «alla stregua di un mero privilegio».
A questo proposito, è invece da escludere che i moduli di rallentamento dell’indicizzazione in progressione inversa rispetto al crescere degli importi dei trattamenti disconoscano il valore della qualità del lavoro prestato.
L’attenzione a quest’ultimo profilo è già espressa, invero, nella liquidazione in misura più elevata del trattamento pensionistico al momento del collocamento a riposo. Si tratta di un meritato riconoscimento dell’impegno e della capacità dimostrati durante la vita economicamente attiva, secondo un apprezzamento che non può mutare neppure in considerazione dei vantaggi maturati dai pensionati soggetti al sistema retributivo – come i ricorrenti nei giudizi principali – rispetto a quelli interamente attratti nell’orbita del sistema contributivo.
A tale proposito, fermo restando che il nesso di certo sussistente tra ammontare dei contributi versati e liquidazione della pensione non deve necessariamente condizionare anche i meccanismi perequativi del trattamento, pur tuttavia è auspicabile che, in un futuro ormai sempre più prossimo, per la categoria di pensionati da ultimo citata l’approccio legislativo possa essere diversamente calibrato.
13.5.– Ancora, con ulteriore censura, i rimettenti prospettano che, come conseguenza del rallentamento della rivalutazione delle pensioni, la popolazione più giovane, con particolare riferimento alla componente femminile, sarebbe disincentivata a impegnarsi nell’attività lavorativa – soprattutto in quella «regolare» – che consente la maturazione di pensioni di più elevato importo.
La tesi non convince, risolvendosi in una mera petizione di principio l’affermazione secondo cui la rivalutazione integrale delle pensioni più alte, di per sé sola, produrrebbe l’effetto di disincentivare il lavoro “in nero” e di incrementare finanche l’occupazione femminile.
La censura non si confronta, infatti, in alcun modo con il peso che normalmente rivestono altri motivi che possono sorreggere scelte individuali di questo tipo. Queste ultime possono essere legate, ad esempio, alla difficoltà delle giovani generazioni a trovare occupazioni corrispondenti alle proprie aspirazioni e retribuite in modo adeguato ai propri percorsi di vita, nonché all’intollerabile ritardo con il quale si va colmando il divario di genere (gender gap) proprio in materia retributiva. Preoccupazioni che attengono, quindi, allo sviluppo della stessa vita lavorativa attiva, più che al destino pensionistico.
13.6.– Infine, i principi di ragionevolezza e di proporzionalità retributiva sarebbero mortificati dalle disposizioni contenute nei numeri 2), 4) e 5) della lettera b) del comma 309 in esame, che non rispetterebbero il divieto di lesione ultra dimidium e l’obbligo di riconoscere incrementi monetari non inferiori al tasso d’interesse legale nel periodo di riferimento, intesi come principi generali dell’ordinamento ricavabili, rispettivamente, dall’art. 1448 cod. civ. e dal combinato disposto degli artt. 1282, comma 1, e 1284, comma 1, cod. civ.
Per considerare destituita di fondamento la censura, è sufficiente evidenziare l’assoluta inidoneità dei principi asseritamente generali che i rimettenti hanno ritenuto di distillare da disposizioni del codice civile attinenti al diritto delle obbligazioni e dei contratti (artt. 1282, comma 1, 1284, comma 1, e 1448 cod. civ.) ad assumere il ruolo di criteri di valutazione della ragionevolezza delle scelte del legislatore in materia previdenziale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA