Pubblicato il
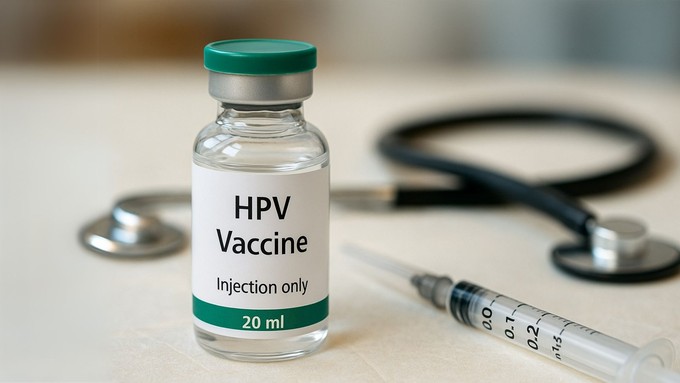
Una legge regionale può subordinare l'accesso all'istruzione alla presentazione di un documento relativo alla vaccinazione anti-HPV, anche solo per attestare il rifiuto o il semplice colloquio informativo?
Con la sentenza n. 48 del 2025, la Corte costituzionale ha risposto di sì, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo contro l'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 22/2024.
Tale disposizione, introdotta come art. 4-bis nella legge reg. Puglia n. 1/2024, prevede che per iscriversi ai percorsi d'istruzione dagli 11 ai 25 anni, compreso l'universitario, occorra presentare una documentazione vaccinale, oppure dichiarare formalmente di non volerla presentare.
Le questioni sollevate
Le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri erano fondate su cinque presunte violazioni:
art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.: invasione della competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione;
art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.: interferenza nei livelli essenziali delle prestazioni (LEP);
artt. 3 e 34 Cost.: lesione del principio di uguaglianza e del diritto allo studio;
art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 9 del GDPR: violazione della disciplina europea sul trattamento dei dati personali.
La Corte ha dichiarato:
inammissibile la questione relativa ai LEP per difetto di motivazione;
non fondate tutte le altre censure.
La decisione
La Corte inquadra la norma nel contesto della campagna vaccinale anti-HPV, ribadendo che tale virus, pur nella maggioranza dei casi asintomatico, è correlato all'insorgenza di diverse forme tumorali. La vaccinazione è gratuita e inclusa nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ma — come rilevato dai dati 2022 — la copertura è ancora lontana dal 95% indicato come obiettivo dal PNPV 2023-2025.
La Regione Puglia ha scelto un approccio di "spinta gentile" (nudge), chiedendo all'atto dell'iscrizione scolastica una documentazione alternativa:
attestazione di vaccinazione,
avvio del programma vaccinale,
rifiuto del vaccino,
colloquio informativo svolto,
oppure un formale rifiuto di presentare qualsiasi documento.
Secondo la Corte, la norma non impone un obbligo ma stimola una riflessione consapevole, senza condizionare l'iscrizione scolastica. La finalità è quella di accrescere la consapevolezza sanitaria, nel rispetto delle competenze regionali in materia di tutela della salute.
Quanto al profilo dell'istruzione, l'intervento non incide su elementi strutturali del sistema nazionale, né crea disomogeneità lesiva del principio di eguaglianza, poiché l'autonomia regionale legittima discipline differenti.
Sul piano del trattamento dei dati personali, la Corte richiama l'art. 9 GDPR che consente il trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante previsti dalla legge. La norma regionale, che tutela i dati raccolti con garanzie adeguate, è conforme sia al diritto UE che al Codice Privacy nazionale.
Conclusione
Secondo la Corte costituzionale, subordinare l'iscrizione a una dichiarazione informativa sulla vaccinazione anti-HPV è legittimo. Non viola il diritto allo studio, non crea disuguaglianze e non impone alcun obbligo vaccinale.
Cosa ci portiamo a casa? Che anche in materia sanitaria, un nudge normativo ben calibrato può rispettare la libertà individuale e al contempo rafforzare la prevenzione collettiva. Un modo per dire: la salute pubblica si costruisce anche con piccoli passi consapevoli.
SENTENZA N. 48
ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 22, recante «Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 luglio 2024, depositato in cancelleria il 1° agosto 2024, iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 12 marzo 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
uditi l’avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Libera Valla per la Regione Puglia;
deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Ritenuto in fatto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato il 1° agosto 2024, iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2024, ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 22, recante «Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite)». Tale disposizione aggiunge l’art. 4-bis nella legge della Regione Puglia 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate). L’art. 4-bis, intitolato «Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano», stabilisce quanto segue: «1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L’attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione» (comma 1). Il comma 2 dispone che «[i] dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e le tutele previste dalla legge».
Il ricorrente propone cinque questioni di legittimità costituzionale, che articola in tre motivi di impugnazione. Nel primo denuncia la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere m) e n), della Costituzione, che attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia, rispettivamente, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull’istruzione, in relazione all’art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 119, quale norma interposta. Nel secondo, lamenta la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e la lesione del diritto allo studio di cui all’art. 34 Cost. Infine, nel terzo motivo censura il contrasto della norma impugnata con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), quale norma interposta.
1.1.– Nel primo motivo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che la normativa in materia di obblighi vaccinali «coinvolge una pluralità di materie riconducibili alle competenze legislative dello Stato, fra le quali rilevano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni […] e le norme generali sull’istruzione» (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 5 del 2018).
L’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. sarebbe violato sotto un duplice profilo: da un lato, la norma impugnata invaderebbe la sfera di competenza legislativa esclusiva statale in quanto regolerebbe «il rapporto fra l’assolvimento degli obblighi vaccinali e gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai percorsi di istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni»; dall’altro, «le previsioni del legislatore regionale seguono percorsi divergenti rispetto a quelli fissati dalla inderogabile disciplina statale di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 73 del 2017, […], quale norma interposta, introducendo, altresì, ulteriori adempimenti a carico dei cittadini». Il ricorrente ricorda che, nella sentenza n. 5 del 2018, questa Corte ha osservato che «le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici (artt. 3, 3-bis, 4 e 5 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017) si configurano come “norme generali sull’istruzione” (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.). Infatti, esse mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. Pertanto, queste norme vengono a definire caratteristiche basilari dell’assetto ordinamentale e organizzativo del sistema scolastico». Nel ricorso è anche richiamata la sentenza n. 186 del 2019 di questa Corte, che ha dichiarato in parte costituzionalmente illegittima una legge della Regione Molise, concernente il rapporto fra l’assolvimento degli obblighi vaccinali e gli adempimenti necessari per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
Quanto all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., esso sarebbe violato perché la norma impugnata rileverebbe nella determinazione dei LEP. Il ricorrente ricorda che i vaccini sono inclusi nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e richiama il vigente Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025, di cui al documento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 2 agosto 2023, n. 193, recante «Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025” e sul documento recante “Calendario nazionale vaccinale”». Il PNPV (Allegato A della citata intesa) ha, fra gli altri, l’obiettivo di «[r]afforzare la prevenzione del cancro della cervice uterina e delle altre malattie HPV correlate» (per HPV si intende il papilloma virus). La norma impugnata, prevedendo che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni sia subordinata alla presentazione di documentazione concernente il vaccino anti-HPV, violerebbe «la competenza statale esclusiva nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni altresì interferendo negli atti nazionali di programmazione sanitaria nei quali i vaccini sono inclusi».
1.2.– Nel secondo motivo il ricorrente osserva che la norma impugnata determinerebbe «una disparita' di trattamento rispetto agli alunni e agli studenti frequentanti scuole e università di altri territori», e potrebbe «costituire un elemento di criticità in caso di trasferimenti di alunni e studenti provenienti da altre regioni, rendendo disomogenea, sul territorio nazionale, la disciplina riguardante l’iscrizione scolastica e universitaria, con possibili riflessi sul rispetto del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost.».
Inoltre, la norma impugnata interferirebbe sul diritto allo studio (art. 34 Cost.), in quanto «l’introduzione di una precisa condizione, inerente la presentazione di documentazione sulla situazione relativa agli adempimenti vaccinali degli alunni e studenti per l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, ancorché con la salvezza di un formale rifiuto», si porrebbe «come limite alla piena fruizione del diritto allo studio riconosciuto incondizionatamente a tutti, vieppiù involgendo anche taluni anni dell’istruzione obbligatoria».
1.3.– Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE, in materia di dati personali. Secondo il ricorrente, tale disposizione pone un divieto generale di trattamento dei dati personali, fra i quali rientrano quelli «relativi alla salute» (paragrafo 1). Il paragrafo 2 dell’art. 9 stabilirebbe le eccezioni al divieto «secondo un elenco da considerarsi tassativo».
In attuazione della disciplina europea, la normativa nazionale circoscriverebbe «la richiesta, da parte del personale scolastico, di avvenuta vaccinazione, esclusivamente ai casi di vaccinazioni obbligatorie e non facoltative come nel caso di specie» (art. 3-bis, comma 2, del citato d.l. n. 73 del 2017, come convertito).
Pertanto, l’acquisizione ed il trattamento di dati personali relativi alla salute, previsti dall’impugnato art. 4-bis, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2024, si porrebbe in contrasto con l’art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE, «il quale sancisce un generale divieto di trattamento dei dati sulla salute, a meno che non ricorrano specifiche esenzioni, che non ricorrono nel caso in esame, trattandosi di vaccinazioni non obbligatorie». A far venir meno il vizio non basterebbe quanto disposto dal comma 2 dell’art. 4-bis («I dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e le tutele previste dalla legge»).
2.– La Regione Puglia si è costituita in giudizio, con atto depositato il 5 settembre 2024.
Secondo la resistente, la norma impugnata si muoverebbe nell’ambito della materia concorrente «tutela della salute». Essa stabilirebbe «misure che sono finalizzate a conseguire l’aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano»; si tratterebbe «di una strategia per rendere la rete informativa a maglie strettissime, così da ridurre i non vaccinati alla sola percentuale di ragazzi e famiglie che scelgono il rifiuto in piena consapevolezza». Il citato art. 4-bis della legge reg. Puglia n. 1 del 2024 avrebbe scelto – come strumento per raggiungere tale obiettivo – «l’iscrizione ai percorsi scolastici per le sue caratteristiche di capillarità e possibilità di coprire più efficacemente il maggior numero della popolazione giovanile interessata». Il rispetto dei confini della potestà legislativa concorrente sarebbe dimostrato dal fatto che la norma impugnata, tramite l’inciso «salvo formale rifiuto», consentirebbe di non presentare alcuna documentazione (relativa al vaccino anti-HPV) al momento dell’iscrizione scolastica, «ciò grazie a un semplice rifiuto (anche solo un “NO”) e senza che ciò determini alcuna conseguenza ai fini della iscrizione». Inoltre, non sarebbe necessario rivelare di aver assunto o meno il vaccino, essendo sufficiente un documento recante un «riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione».
Con riferimento specifico alla asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., la Regione Puglia osserva che la norma impugnata «non “regola il rapporto fra l’assolvimento degli obblighi vaccinali e gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai percorsi di istruzione 11-25 anni”», ma si limiterebbe a fare in modo che i soggetti interessati siano «resi consapevoli dell’esistenza del vaccino e della sua somministrazione gratuita», dovendo prendere posizione sulla produzione della documentazione vaccinale, al momento dell’iscrizione scolastica. L’art. 4-bis non inciderebbe in alcun modo sul diritto allo studio e non sarebbe configurabile quale norma generale sull’istruzione. Esso rientrerebbe nella materia «tutela della salute», riguardando il «dovere di informazione sui rischi connessi a determinate patologie»; il sistema dell’istruzione, in tale contesto, sarebbe «solo uno strumento applicativo e non l’oggetto diretto dell’intervento legislativo regionale».
Inoltre, non sussisterebbe alcun contrasto tra la norma impugnata e l’art. 3-bis del d.l. n. 73 del 2017, come convertito, in quanto tale disposizione disciplinerebbe le vaccinazioni obbligatorie, mentre il vaccino anti-HPV è raccomandato, non obbligatorio.
Con riferimento specifico alla asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., la resistente eccepisce, innanzi tutto, l’inammissibilità del motivo «per difetto argomentativo», in quanto il ricorrente sosterrebbe in modo apodittico che la norma impugnata violerebbe la competenza statale sui LEP «interferendo negli atti nazionali di programmazione sanitaria nei quali i vaccini sono inclusi». In mancanza di ulteriori precisazioni, non sarebbe «ben chiaro in cosa consiste questa “interferenza”», dal momento che la disposizione in esame, senza prevedere alcun obbligo, si inserirebbe «in maniera armonica nell’ambito della programmazione vaccinale», rafforzando l’informazione sul vaccino. Oltre a essere inammissibile, il motivo de quo sarebbe «manifestamente infondato».
Quanto al secondo motivo di ricorso (assunta violazione degli artt. 3 e 34 Cost.), secondo la Regione Puglia, la mancata introduzione di un qualsiasi obbligo vaccinale e, in generale, di conseguenze in caso di rifiuto di presentare la documentazione vaccinale escluderebbe che la norma impugnata «possa determinare ripercussioni sul principio di uguaglianza o di diritto allo studio».
Infine, quanto al terzo motivo (violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE), la Regione ne argomenta la non fondatezza richiamando la sentenza n. 271 del 2005 di questa Corte e rileva che «il legislatore regionale, legiferando nell’ambito della propria potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e prevedendo il trattamento di dati personali al fine del perseguimento di un interesse pubblico rientrante nei casi in cui questo e' possibile ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE 2016/679, non e' intervenuto in alcuna maniera sul sistema di organizzazione e disciplina di tali dati, preoccupandosi, al contrario, di stabilire» che «[i] dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e le tutele previste dalla legge» (art. 4-bis, comma 2).
3.– Il 23 settembre 2024 l’associazione Coordinamento del movimento italiano per la liberta' di vaccinazione (COMILVA ODV) ha depositato opinione scritta ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Tale opinione è stata ammessa con decreto presidenziale del 16 gennaio 2025.
Il 17 febbraio 2025 la Regione Puglia ha depositato una memoria integrativa, ribadendo i propri argomenti, anche alla luce dell’opinione dell’amicus curiae.
Il 19 febbraio 2025 anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria integrativa, ribadendo i propri argomenti e osservando che, nonostante la possibilità del rifiuto di produrre il documento, la norma impugnata contemplerebbe un ulteriore adempimento ai fini dell’iscrizione scolastica.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, impugna l’art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024. Tale disposizione aggiunge l’art. 4-bis nella legge reg. Puglia n. 1 del 2024. L’art. 4-bis, intitolato «Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano», stabilisce quanto segue: «1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L’attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione» (comma 1). Il comma 2 dispone che «[i] dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e le tutele previste dalla legge».
Il ricorrente ritiene che la norma impugnata vìoli: a) l’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., in quanto invaderebbe la sfera di competenza legislativa esclusiva statale, regolando «il rapporto fra l’assolvimento degli obblighi vaccinali e gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai percorsi di istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni»; inoltre, «le previsioni del legislatore regionale seguono percorsi divergenti rispetto a quelli fissati dalla inderogabile disciplina statale di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 73 del 2017, […], quale norma interposta, introducendo, altresì, ulteriori adempimenti a carico dei cittadini»; b) l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, prevedendo che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni sia subordinata alla presentazione di documentazione concernente il vaccino anti-HPV, violerebbe «la competenza statale esclusiva nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni altresì interferendo negli atti nazionali di programmazione sanitaria nei quali i vaccini sono inclusi»; c) l’art. 3 Cost., poiché renderebbe disomogenea, sul territorio nazionale, la disciplina riguardante l’iscrizione scolastica e universitaria, con possibili riflessi sul rispetto del principio di uguaglianza; d) l’art. 34 Cost., in quanto «l’introduzione di una precisa condizione, inerente la presentazione di documentazione sulla situazione relativa agli adempimenti vaccinali degli alunni e studenti per l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, ancorché con la salvezza di un formale rifiuto», si porrebbe «come limite alla piena fruizione del diritto allo studio riconosciuto incondizionatamente a tutti»; e) l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE, che pone un divieto generale di trattamento dei dati personali, fra i quali rientrano quelli relativi alla salute.
2.– Prima di esaminare le singole questioni, è opportuno ricostruire brevemente il contesto in cui si colloca la norma impugnata, con riferimento alla campagna vaccinale statale (punto 2.1.; su tale campagna si è già soffermata la sentenza n. 181 del 2023), e di seguito illustrarne il contenuto (punto 2.2.).
2.1.– L’infezione da HPV (dall’inglese Human papilloma virus) è molto frequente nella popolazione e si trasmette prevalentemente per via sessuale. La maggioranza delle infezioni è transitoria e asintomatica. Tuttavia, se l’infezione persiste, può manifestarsi con una varietà di lesioni della pelle e delle mucose, a seconda del tipo di HPV coinvolto. Alcuni tipi di HPV sono definiti ad alto rischio oncogeno poiché associati all’insorgenza di neoplasie. Il tumore più comunemente associato all’HPV è il carcinoma del collo dell’utero (o della cervice uterina). L’HPV può provocare, però, altri tumori nell’apparato genitale e in quello oro-faringeo, sia nella donna che nell’uomo (si veda la scheda dell’Istituto superiore di sanità, del 6 marzo 2020).
Dunque, anche se solo una minoranza delle infezioni sfocia in esiti cancerosi, l’HPV rappresenta un importante problema sanitario in Italia.
Tenuto conto di ciò, nel nostro Paese nel 2008 è partita la campagna di vaccinazione gratuita per le ragazze nel dodicesimo anno di età, preceduta dal parere del Consiglio superiore di sanità dell’11 gennaio 2007, che illustrava l’efficacia e la sicurezza del vaccino, nonché dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 dicembre 2007.
Si sono poi susseguiti a livello statale vari piani nazionali di prevenzione vaccinale (PNPV), che hanno contemplato la profilassi anti-HPV. Allo stesso tempo, il d.P.C.m. 12 gennaio 2017 ha inserito il vaccino anti-HPV fra i livelli essenziali di assistenza (si vedano gli artt. 2 e 4, comma 2, lettera o, e l’Allegato 1).
Attualmente, opera il PNPV 2023-2025 (Allegato A alla già citata intesa del 2 agosto 2023), che prevede la vaccinazione anti-HPV nel dodicesimo anno di età, per femmine e maschi, fino a 14 anni inclusi, e poi un «programma di recupero (catch up), per le donne almeno fino a 26 anni, anche utilizzando l’occasione opportuna della chiamata al primo screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero, e per gli uomini almeno fino a 18 anni inclusi, con mantenimento della gratuita' per tutte le dosi del ciclo vaccinale, qualora non siano stati precedentemente vaccinati o non abbiano completato il ciclo vaccinale». Il Piano 2023-2025 fissa un obiettivo di copertura vaccinale (ciclo completo) pari almeno al 95 per cento a 15 anni.
I programmi vaccinali sopra indicati non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Già la sentenza n. 5 del 2018 di questa Corte dava atto, in generale, di «una tendenza al calo delle coperture vaccinali». La copertura vaccinale anti-HPV è stata poi indebolita dall’impatto della pandemia da COVID-19. Dal PNPV 2023-2025 risulta che, nel 2021, «le coperture relative alla vaccinazione HPV sono in generale miglioramento rispetto all’anno precedente, seppur ben al di sotto dei target primari». Al 31 dicembre 2022 in Italia la copertura vaccinale (ciclo completo) era del 69 per cento per le quindicenni e del 56 per cento per i quindicenni (Documento del Ministero della salute sulle coperture vaccinali per HPV al 31 dicembre 2022). L’obiettivo del 95 per cento, dunque, è ancora molto lontano.
2.2.– La Regione Puglia ha avviato la campagna vaccinale anti-HPV nel settembre 2008. Con la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, essa ha disciplinato uno specifico «Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate».
La disposizione impugnata inserisce l’art. 4-bis nella legge regionale appena citata. Tale articolo, come visto (supra, punto 1), stabilisce che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, sia subordinata alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l’avvio del programma di somministrazione, il rifiuto della somministrazione o l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino. È però contemplata la possibilità di esprimere il «formale rifiuto» di produrre alcun documento.
La produzione dell’attestato non è, dunque, prevista come condizione dell’iscrizione scolastica. La norma impugnata ha il fine di indurre alla vaccinazione anti-HPV o, almeno, di assicurare il “dissenso informato”, cioè di far sì che il rifiuto avvenga con piena consapevolezza. Tale obiettivo è perseguito, però, inducendo il genitore o il giovane maggiorenne a riflettere sulla mancata vaccinazione anti-HPV, non imponendogli la produzione di un attestato. Si tratta di una “spinta gentile” (nudge), cioè di un approccio che mira ad influenzare le decisioni pur salvaguardando la libertà di scelta.
3.– Ciò premesso, si possono affrontare le singole questioni promosse dal ricorrente.
Cominciando dai profili di rito, la Regione Puglia eccepisce l’inammissibilità della seconda questione (asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), «per difetto argomentativo».
L’eccezione è fondata.
Il ricorrente richiama le norme pertinenti del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che determina i LEA, e il contenuto del PNPV 2023-2025, ma non spiega perché la disposizione impugnata inciderebbe sulla loro attuazione. L’interferenza viene affermata in modo apodittico, mentre un’argomentazione sarebbe stata necessaria, dato che l’impugnato art. 4-bis, lungi dall’ostacolare l’erogazione del vaccino anti-HPV (che rappresenta un LEA), mira ad agevolarla. Come detto, la norma oggetto di censura ha lo scopo di accrescere l’informazione sul vaccino in questione e la copertura vaccinale e, dunque, risulta coerente con gli indirizzi statali, sia legislativi (si vedano gli artt. 1, comma 6-ter, e 2 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito) che sub-legislativi (si veda il già citato PNPV 2023-2025).
Ciò considerato, il motivo in esame si presenta privo di una sufficiente motivazione e, dunque, inammissibile (ex multis, sentenze n. 133 e n. 95 del 2024, n. 155 e n. 125 del 2023).
4.– La prima questione (dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.) non è fondata.
Questa Corte ha in diverse occasioni definito la portata delle «norme generali sull’istruzione», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (da ultimo, sentenze n. 192 e n. 168 del 2024 e n. 223 del 2023, nonché ordinanza n. 199 del 2024). Esse consistono in «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali» (sentenza n. 200 del 2009, ribadita dalle sentenze n. 92 del 2011 e n. 309 del 2010). La sentenza n. 200 del 2009 ha, inoltre, individuato l’ambito delle «norme generali sull’istruzione» alla luce degli artt. 33 e 34 Cost. e degli atti legislativi statali che le definiscono, cioè della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), e dei relativi decreti legislativi attuativi.
La norma impugnata è chiaramente estranea all’ambito di quelle che definiscono «la struttura portante del sistema nazionale di istruzione» e che mirano ad assicurare una «offerta formativa omogenea», così come agli oggetti regolati dagli artt. 33 e 34 Cost., dalla legge n. 53 del 2003 e dai decreti attuativi.
Quanto alle sentenze n. 186 del 2019 e n. 5 del 2018 di questa Corte (richiamate nel ricorso), esse hanno qualificato come «norme generali sull’istruzione» «le disposizioni della legislazione statale che riguardano l’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici».
La norma impugnata è di tipo diverso. In primo luogo, essa non attiene ad un vaccino obbligatorio, ma solo raccomandato, e dà chiaramente atto di ciò, dal momento che indica – fra i possibili oggetti dell’attestato richiesto – anche il rifiuto del vaccino e il mero svolgimento del colloquio informativo. In secondo luogo, l’art. 4-bis non prevede un adempimento necessario per l’iscrizione, contemplando espressamente la possibilità di rifiutare la produzione documentale richiesta dalla norma stessa.
Non sussiste neppure un contrasto tra l’impugnato art. 4-bis e l’art. 3-bis del d.l. n. 73 del 2017, come convertito, evocato dal ricorrente quale norma interposta. Questa disposizione statale, infatti, riguarda i vaccini obbligatori e prevede una procedura che si svolge dopo l’avvenuta iscrizione scolastica e che può condurre, nel caso in cui l’inadempimento dell’obbligo vaccinale non venga sanato, all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e – nel solo caso degli asili nido e delle scuole materne – alla decadenza dall’iscrizione. Tale procedura resta ferma: la norma censurata aggiunge solo un adempimento di altro tipo, prima dell’iscrizione, in relazione ad un vaccino non obbligatorio. Le due norme, dunque, agiscono su piani diversi.
La previsione impugnata può essere qualificata come una disposizione di dettaglio rientrante in due materie concorrenti: nella «tutela della salute», dal punto di vista teleologico, e nell’«istruzione», dal punto di vista oggettivo. Questa Corte ha ricondotto alla competenza legislativa regionale gli aspetti organizzativi dell’istruzione (ad esempio, sentenze n. 284 del 2016 e n. 120 del 2005), mentre ha qualificato come principi fondamentali «criteri, obiettivi, direttive o discipline […] tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione» (sentenze n. 284 del 2016 e n. 200 del 2009). La norma in questione incide in misura assai limitata sulle modalità di iscrizione scolastica, al fine di indurre alla vaccinazione anti-HPV, in coerenza con il PNPV 2023-2025, che indica fra gli obiettivi quello di «[r]afforzare la prevenzione del cancro della cervice uterina e delle altre malattie HPV correlate» e quello di «[r]afforzare la comunicazione in campo vaccinale», prescrive di «sviluppare una estesa campagna comunicativa e informativa» anche in ambito scolastico e riporta, come esempio di contenuti della campagna comunicativa, il «[c]onsenso e dissenso informato in ambito vaccinale».
5.– La terza questione (asserita violazione dell’art. 3 Cost.) non è fondata.
Secondo il ricorrente, la norma impugnata renderebbe «disomogenea, sul territorio nazionale, la disciplina riguardante l’iscrizione scolastica e universitaria, con possibili riflessi sul rispetto del principio di uguaglianza».
Come si è rilevato più volte, la censura con cui si contesta una legge regionale in quanto differenzia la popolazione di quel territorio da quella del resto d’Italia «contraddice l’esistenza stessa dell’autonomia legislativa regionale» (sentenza n. 119 del 2019); accertato che una regione «ha operato nell’ambito delle competenze a essa spettanti, è sufficiente osservare che “il riconoscimento stesso della competenza legislativa della Regione comporta l’eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti dell’art. 117 della Costituzione (v. sentenza n. 447 del 1988)” (sentenza n. 277 del 1995, punto 6. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 241 del 2018).
6.– La quarta questione (dedotta violazione dell’art. 34 Cost.) non è fondata.
Nella prospettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, l’impugnato art. 1 si porrebbe «come limite alla piena fruizione del diritto allo studio riconosciuto incondizionatamente a tutti». In realtà, il fatto che l’adempimento richiesto dall’art. 4-bis possa tradursi in un semplice rifiuto di produrre la documentazione vaccinale esclude che possa verificarsi una lesione del diritto allo studio. Questa Corte ha accertato la violazione o la possibile violazione di tale diritto in relazione a norme di ben altro impatto: si veda la sentenza n. 42 del 2021 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma legislativa della Provincia autonoma di Trento che favoriva i residenti in provincia nell’accesso ai corsi universitari) e la sentenza n. 42 del 2017 (riguardante una norma che consentiva l’attivazione di corsi universitari in lingua straniera).
7.– L’ultima questione (asserita violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE) non è fondata.
Fin dalla sentenza n. 94 del 1995 (anticipata dalla sentenza n. 384 del 1994), questa Corte ha statuito che, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, «non si rinviene, come invece nei giudizi in via incidentale, alcun ostacolo processuale in grado di precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una comunitaria». In relazione al giudizio in via incidentale, si è poi rilevato che, «[p]erché questa Corte scrutini nel merito le censure di violazione di una normativa di diritto dell’Unione direttamente applicabile, è necessario che la questione posta dal rimettente presenti un “tono costituzionale”, per il nesso con interessi o princìpi di rilievo costituzionale» (sentenza n. 181 del 2024; nello stesso senso, sentenze n. 210 del 2024, n. 1 e n. 31 del 2025 e ordinanza n. 21 del 2025).
Secondo il ricorrente, la norma impugnata contrasterebbe con l’art. 9 del GDPR (General Data Protection Regulation), che pone un divieto generale di trattamento dei dati personali, fra i quali rientrano quelli «relativi alla salute» (su tale norma si vedano, da ultimo, Corte di giustizia dell'Unione europea, ottava sezione, sentenza 19 dicembre 2024, causa C-65/23, MK; grande sezione, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-21/23, ND; terza sezione, sentenza 21 dicembre 2023, causa C-667/21, ZQ).
In realtà, l’art. 9, paragrafo 2, del GDPR stabilisce che il divieto di trattare dati relativi alla salute «non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: […] g) il trattamento e' necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato».
Tale norma è stata attuata dall’art. 2-sexies, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nei seguenti termini: «I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato». Il comma 2 dello stesso art. 2-sexies precisa che «si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: […] u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica».
Dunque, nel GDPR una delle “basi giuridiche” che giustificano il trattamento dei dati sensibili è la norma legislativa interna, che persegua un fine di interesse pubblico nel rispetto del principio di proporzionalità, prevedendo «misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali […] dell’interessato» (art. 9, paragrafo 2, lettera g). La norma impugnata risulta conforme a tale standard perché ha lo scopo di aumentare la copertura vaccinale e non richiede che l’interessato riveli il proprio status di vaccinato o non vaccinato, consentendo che si attesti il mero svolgimento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione, o anche che si rifiuti la produzione di alcun documento. Inoltre, occorre ricordare che, in base all’art. 1, comma 2, della legge impugnata, «[i] dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e le tutele previste dalla legge».
Per tali ragioni, il contrasto con l’art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE è da ritenere insussistente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 22, recante «Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite)», sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 34, 117, secondo comma, lettera n), e 117 primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA